Sarà che ieri sera sono andata a sentire degli amici suonare i Nirvana. Sarà che ho deciso che a giugno andrò al concerto dei Pearl Jam. Fatto sta che oggi mi sono alzata con l’idea di scrivere di Anni luce di Andrea Pomella, giornalista de Il Fatto Quotidiano, libro pubblicato dalla Add (casa editrice indipendente che riserva continue belle sorprese), tra i 12 candidati al Premio Strega 2018.
Comunque sia. Vado dritta alla ragione per cui ne scrivo: non ricordo di aver letto parole così centrate per raccontare che cos’è stato il grunge e perché abbia costituito qualcosa di così dirompente e lacerante nella vita di chi vi si è trovato in mezzo.
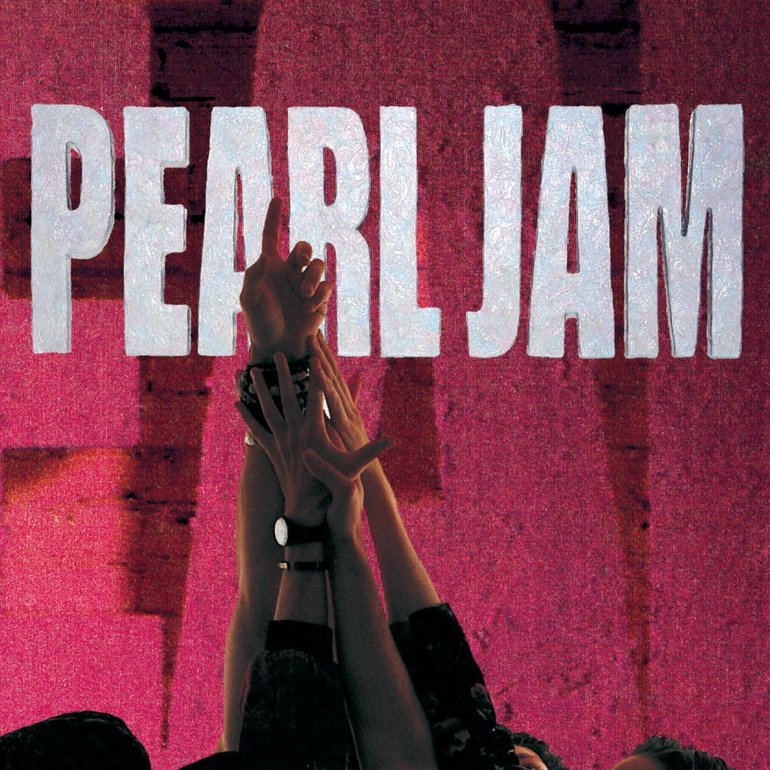
Il punto di partenza è un anniversario: il 25° dall’uscita di Ten, primo album dei Pearl Jam, «il treno che travolse la mia giovinezza» scrive Pomella. Ricorrenza a cui dedica un pezzo: «E bastò questo perché il treno passasse di nuovo sopra le mie rovine di ultraquarantenne, stavolta trascinandosi dietro un oceano di ricordi»… e la scrittura, appunto, di Anni Luce.
Ricordi, dicevamo, che riportano l’autore a quel 1991, a un’amicizia e a un viaggio, al disincanto di una generazione. L’amicizia − «solida, sbilenca, acida» − è quella con chi ai Pearl Jam lo ha iniziato: «Ossia il compagno di sbronze, l’amico, il viaggiatore, il chitarrista geniale, il folle, il saggio, l’esagerato, l’imprevedibile, il lunatico Q».
E poi l’incontro con Ten: «Quella sera Q disse: “Devi sentire questa”, estraendo dal vano del cruscotto una copertina rosa su cui campeggiavano cinque braccia protese verso l’alto. La infilò nell’autoradio, e poco dopo partì un lento interludio strumentale. L’intro fluttuante e misteriosa, precedeva una sventagliata di chitarre e batteria da cui prendeva avvio la cupa confessione di un serial killer intonata da una voce roca e febbrile. Venivano da Seattle, si chiamavano Pearl Jam, e quelle erano le prime parole di Once, l’incipit di Ten, il loro album d’esordio: “I admit it, what’s to say…” ».
Credo che tutti coloro che hanno incrociato il grunge, ricordino l’esatta collocazione temporale di quel momento. Per me fu la primavera del 1992, nel garage dismesso della zia di un compagno di scuola che lo aveva risistemato con un paio di poltrone, uno stereo e qualche poster appeso alle pareti. In un pomeriggio pervaso dall’imbarazzo adolescenziale di gestire uno spazio e un tempo che contenessero solo noi due, infilò una cassetta nello stereo e ne riavvolse il nastro. Mi mise addosso un paio di cuffie enormi e schiacciò play. Per la prima volta ascoltavo la voce di Kurt Cobain che cantava solo per me. Era Nevermind che dischiudeva una traccia dopo l’altra − da Smell like Teen Spirit a In bloom e Come as you are, giù fino a Something in the way − tutte le sue dolorose meraviglie.
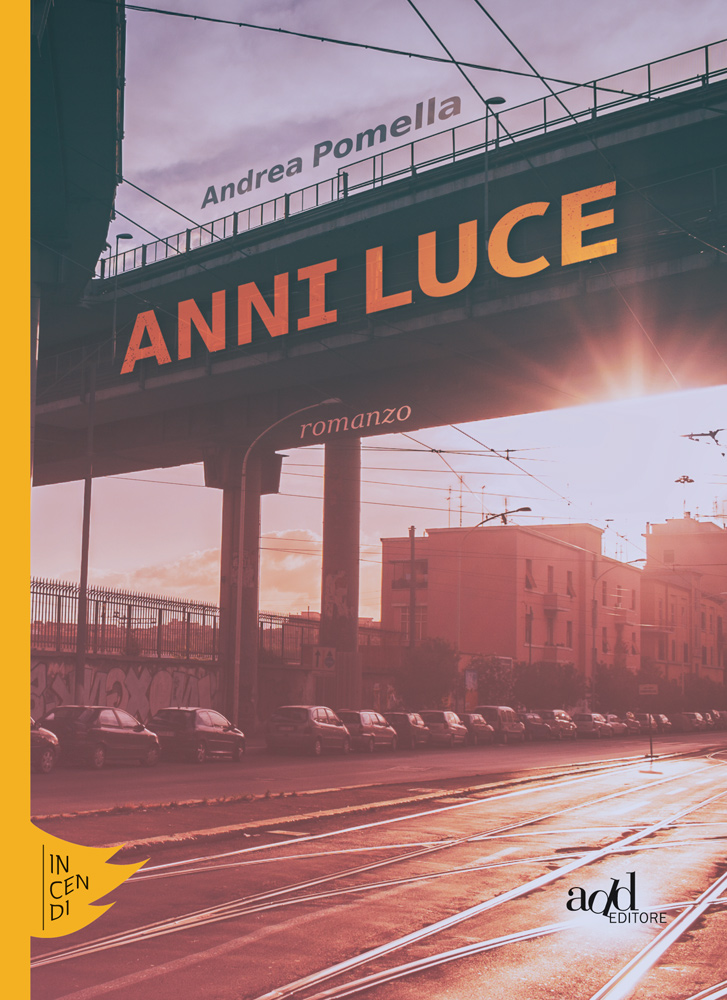 Anni luce è il racconto degli eccessi di quella generazione piena di dolore, delle sbronze, della droga e del vuoto, del viaggio con Q in giro per l’Europa chitarra in spalla. E di pagina in pagina quel racconto disegna anche la geografia culturale che molti di noi hanno condiviso: da Burroughs a Kerouac, passando per Henry Miller fino a Trainspotting (state canticchiando Lust for live?) di cui scrive: «C’erano il sarcasmo, le nevrosi, la ferocia, la volontà di annullamento di una generazione che senza mezzi termini, come avevano cantato i Sex Pistols vent’anni prima, rifiutava il futuro. Una generazione che non si lamentava, che non combatteva per il proprio avvenire, una gioventù che passava il tempo a fuggire perché l’altrove era diventato quasi naturale». E rispetto a questo, per dirne una: abbiamo mai opposto una resistenza collettiva di fronte all’arretrare delle conquiste del diritto del lavoro? Comunque sia, in Anni luce, da Hungher strike dei Temple of the dog a Jeremy dei Pearl Jam, c’è anche la continua scoperta di aneddoti, ragioni, retroscena di canzoni e band.
Anni luce è il racconto degli eccessi di quella generazione piena di dolore, delle sbronze, della droga e del vuoto, del viaggio con Q in giro per l’Europa chitarra in spalla. E di pagina in pagina quel racconto disegna anche la geografia culturale che molti di noi hanno condiviso: da Burroughs a Kerouac, passando per Henry Miller fino a Trainspotting (state canticchiando Lust for live?) di cui scrive: «C’erano il sarcasmo, le nevrosi, la ferocia, la volontà di annullamento di una generazione che senza mezzi termini, come avevano cantato i Sex Pistols vent’anni prima, rifiutava il futuro. Una generazione che non si lamentava, che non combatteva per il proprio avvenire, una gioventù che passava il tempo a fuggire perché l’altrove era diventato quasi naturale». E rispetto a questo, per dirne una: abbiamo mai opposto una resistenza collettiva di fronte all’arretrare delle conquiste del diritto del lavoro? Comunque sia, in Anni luce, da Hungher strike dei Temple of the dog a Jeremy dei Pearl Jam, c’è anche la continua scoperta di aneddoti, ragioni, retroscena di canzoni e band.
Ma più di tutto c’è, a 25 anni di distanza, la lucida capacità di spiegare le radici del grunge, in un mondo senza più il Muro di Berlino, svuotato di ideologie, dove gli sforzi di alcuni (le ricordate le autogestioni e la Pantera?) sembravano davvero «la contraffazione di ciò che aveva fatto la generazione dei nostri genitori alla fine degli anni Sessanta e il decennio successivo»:
«Quei ragazzi volevano replicare un modello romantico, incastonare il fascino della rivolta nell’ambra di un presente indistinto. La maggior parte di loro voleva essere poeticamente sbaragliata, come lo era stata la generazione dei loro padri. Ero annoiato da questo gioco e me ne chiamai fuori in fretta. Il problema era rimpiazzarlo con qualcosa di diverso. E questo, credo, fu l’assillo principale dei ventenni di allora − perlomeno di quelli che la pensavano come me −, ma anche la scintilla da cui scaturì la cosa che fu chiamata grunge. All’inizio una moda musicale arrivata da Seattle, ossia dalla periferia dell’America al tempo di Bush senior, l’America alle prese con la contrazione post-reganiana e con la Prima Guerra del Golfo, ma che presto si tramutò in una vera e propria filosofia di vita. Una filosofia ribelle, depressa, pessimista, che aveva come unico sfogo la pulsione suicida. La più lucida e disperata tra le mode giovanili dai tempi del decadentismo francese».
Cosa ne è stato? C’è chi ha scelto la vita adulta («Inutile che io stia qui a dire che, per quanto mi riguarda, la mia storia personale poi è andata in tutt’altro verso» scrive Pomella) lasciando sotto traccia quel «disagio» che di tanto in tanto torna a pungere e chi, invece, ha continuato ad accelerare fino a scomparire.


Ehi a mezzanotte su Rai cinque c’È live in london dei placebo